Un forte appello per creare le condizioni di dialogo tra i soggetti politici che si riconoscono in valori comuni per costruire una forza popolare , liberale e riformista.
Questo il messaggio che cogliamo nel Saggio “La Visione”.
Utile la lettura del prologo del libro scritto da Alessandro Barbano edito da Mondadori ,l’autore continua il lavoro iniziato nel 2018 con il saggio dal titolo “Troppi Diritti ” proseguito nel 2019 con il saggio “Le dieci Bugie ” che sfocia oggi con” La Visione”
“Le emergenze della Società non si risolvono senza la Politica”

Alessandro Barbano
Il Prologo
“Questo libro è scritto per smentire un luogo comune: che dalle grandi emergenze si esce senza la politica. Da sempre un simile pensiero pervade le società più deboli, di fronte alle crisi che mettono in discussione il loro equilibrio. L’agguato del coronavirus al pianeta non si è sottratto a questa regola. Scatenando un sentimento di angoscia mai visto dal dopoguerra, tanto nella classe dirigente quanto tra i cittadini, ha innescato nelle democrazie difese non sempre ben calibrate nelle proporzioni e nella mira contro il nemico. Alcuni Paesi hanno sviluppato una malattia autoimmune, per la quale un eccesso di reazione difensiva s’indirizza contro il sistema a difesa del quale era stata attivata.
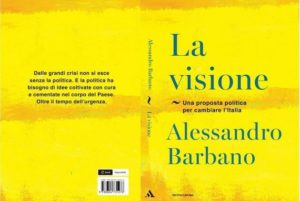
Una parte degli storici riconduce a questo meccanismo la genesi di alcuni totalitarismi. Ciò riguarda soprattutto i fascismi, che s’imposero in Europa all’inizio del Novecento, aggredendo le democrazie in un’era iniziale del loro sviluppo, quando ancora le barriere culturali tra le classi sociali tenevano fuori dal gioco una parte della cittadinanza. La pandemia è intervenuta invece in una stagione avanzata e per certi versi senile della democrazia, e in coincidenza con quella che potremmo definire la cronicizzazione del populismo. Una fase in cui l’utopia antisistema ha già ampiamente fallito il tentativo di surrogare la democrazia rappresentativa, ma si è insinuata negli estenuati processi di questa sotto forma di una demagogia strisciante. Che va ben oltre il perimetro dei partiti e dei leader che se la intestano, per diventare uno slittamento inconsapevole del pensiero, comune tanto ai rappresentanti quanto ai rappresentati.
Se si eccettua l’Ungheria, dove in nome dello stato di eccezione il Parlamento ha consegnato al premier Viktor Orban pieni poteri, la crisi del coronavirus non ha fin qui prodotto concentrazioni istituzionali né compressioni democratiche visibili in Europa. Cionondimeno, la lotta alla pandemia ha enfatizzato il confronto tra strategie diverse, che coincidono con visioni alternative del mondo: da una parte l’isolamento nazionalista, dall’altra la solidarietà globale.
In una prima fase un sentimento crescente di angoscia collettiva ha rafforzato il valore simbolico dell’idea di Stato nazione. La corsa tardiva e contemporanea di molti governi al reperimento dei mezzi sanitari necessari ad arginare il contagio ha posto gli Stati in competizione tra loro. La catena di approvvigionamento globale ha così mostrato tutta la sua fragilità, alimentando l’idea del protezionismo. Alla spinta sulle localizzazioni produttive hanno corrisposto controlli più stringenti alle frontiere. L’impatto di questi processi sul commercio globale e sulla cooperazione internazionale potrebbe avere un riflesso non ancora pienamente considerato sulla salute di istituzioni come l’Unione Europea e sul destino delle relazioni tra le grandi potenze come Stati Uniti e Cina.
Ma a questa visione si è presto affiancata una consapevolezza opposta: che la pandemia è un fenomeno dagli effetti globali che solo una governance internazionale può contrastare. La conversione delle cancellerie e delle istituzioni europee verso un grande piano continentale di misure fiscali è un segnale a favore di una ritrovata solidarietà politica.
L’aver ancorato la sua misura più consistente, il Recovery Fund, al bilancio europeo è, insieme, un’incompiuta e una scommessa. Un’incompiuta perché evita ai singoli Stati di dover garantire l’emissione di titoli di debito pubblico a vantaggio dei Paesi più colpiti dalla crisi; una scommessa perché impegna le cancellerie a rimpinguare il bilancio dell’Unione come prova di un investimento nella costruzione politica sovranazionale. Di fronte alla recessione che seguirà alla crisi sanitaria e di cui si colgono già i primi consistenti segnali, questa volontà politica sarà chiamata a una prova decisiva. Se il nazionalismo prevarrà, come l’impulso autoimmune fuori controllo della democrazia, una prima amputazione della politica, in nome dell’emergenza, riguarderà la sua proiezione europea.
Tuttavia c’è uno spazio interno ai singoli Paesi, in cui lo stesso fenomeno ha già messo alla prova la politica. Si coglie nell’alternativa tra due visioni epidemiologiche con cui è stata fin qui condotta la lotta alla pandemia. La prima punta a una sorveglianza totalitaria, assumendo l’emergenza come la giustificazione per una strategia segregazionista, sospendendo o limitando il controllo parlamentare con i decreti d’urgenza, fermando del tutto la società e l’economia e sanzionando duramente chi trasgredisce i divieti. La seconda investe su una responsabilizzazione dei cittadini isolando i malati e controllandoli con la tecnologia, limitando la privacy ma con rinunce sociali e stop economici meno onerosi.
La scelta di uno dei due modelli qui tracciati non è stata casuale. Non è vero, come pure si è sostenuto, che è stata dettata dall’aggressività con cui il virus ha colpito ogni singolo Paese e dalla dotazione tecnologica dei diversi sistemi sanitari e di prevenzione. In realtà, come vedremo, determinanti sono stati lo stato di salute dei sistemi democratici coinvolti e i presupposti culturali su cui si fondano.
La pandemia ha testato il livello di efficienza delle democrazie. Per l’Italia è stata una Caporetto. Di cui portano responsabilità, in egual grado, la politica e gli scienziati, i leghisti e le sinistre a Palazzo, la sanità lombarda e il governo. Il numero delle vittime, tra cui medici e paramedici in una misura che non ha eguali, interi ospedali e residenze assistenziali contagiati rappresentano un bilancio disastroso, sul quale invano si spargono spiegazioni improbabili, come l’anzianità della popolazione, la convivenza dei giovani in casa, l’inquinamento e altre amene leggende sanitarie.
Ma l’idea che gli epidemiologi più attenti, in patria e all’estero, hanno del caso italiano è un’altra:
1) abbiamo ospedalizzato la crisi trasformando le strutture sanitarie in moltiplicatori del contagio;
2) abbiamo inseguito il virus cercando di placcarlo alle spalle, ma facendocelo sempre sfuggire, fin dal blocco dei voli con la Cina – che si è rivelato un boomerang, perché ha impedito di tracciare i passeggeri rientranti – per proseguire con le chiusure tardive delle sorgenti dell’epidemia in Lombardia;
3) abbiamo per settimane rinunciato a estendere il numero dei tamponi, utili a tracciare una mappa del contagio sul territorio;
4) in alcune regioni abbiamo ricoverato i malati di Covid-19 nelle residenze per anziani, trasformandole in breve in cimiteri virali, con delibere regionali nelle quali si fa fatica a comprendere dove finisce l’improntitudine e dove inizia lo sprezzo per la vita dei più deboli.
È innegabile che ci siano handicap cronici del sistema sanitario che hanno giocato contro. Il primo riguarda la medicina di base, che è stata portata fuori dalla gestione dell’emergenza per compiacere a una prete- sa corporativa dei camici bianchi. Lo smantellamento di questo diaframma tra la malattia e l’ospedale è un deficit cronico, ben noto ai ministri che hanno governato la sanità negli ultimi decenni. Non a caso, durante i week-end invernali le astanterie degli ospedali del Centro-Sud scoppiano di barelle a ogni epidemia di influenza, offrendo alle telecamere dei Tg uno spettacolo indecoroso.
Il secondo handicap riguarda le infrastrutture rianimatorie: all’inizio della crisi in Italia c’erano 5090 posti letto di terapia intensiva, contro i 28.000 della Germania. Che ha avuto i tre quarti dei nostri contagi e un numero di ricoverati persino maggiore, ma ha pagato un prezzo di vite incommensurabilmente più basso.
Di fronte a questi numeri si riavvolge, come in un film, il biennio gialloverde e giallorosso, passato a distribuire redditi di cittadinanza e pensioni a gogò, e a discutere per mesi e mesi di come fermare prima gli immigrati e poi la prescrizione. Che cosa è stato fatto, in questo tempo, per aumentare l’efficienza dei servizi nel nostro Paese? E quando, a gennaio, tutti i virologi ormai sapevano che il virus sarebbe arrivato anche in Italia, che cosa è stato fatto per non trovarci nudi, per settimane senza neanche la protezione di una mascherina? Può assolverci il fatto che altre grandi democrazie, come Stati Uniti e Spagna, si siano scoperte altrettanto impreparate?
Siamo entrati nel tunnel dei contagi convinti di essere assistiti dalla migliore sanità del mondo. E ne siamo usciti a pezzi. Ciascuno degli errori qui indicati ha una matrice politica e culturale ben precisa. Il gap infrastrutturale della sanità e l’impreparazione rispetto all’arrivo del virus sono entrambi ascrivibili a un cronico deficit di gestione dei servizi pubblici, che solo in parte può spiegarsi con i contestati, e non sempre reali, tagli alla sanità. L’insufficiente dotazione di posti di terapia intensiva risponde a una mancata riorganizzazione del modello ospedaliero attorno alle priorità terapeutiche del territorio. Dove la gestione regionale transige con interessi corporativi che sono da sempre fonti del consenso elettorale. E dove l’indirizzo e il coordinamento dello Stato sono venuti perdendo ruolo negli ultimi due decenni.”

Alessandro Barbano (Lecce, 26 luglio 1961), è giornalista e saggista: vicedirettore del Corriere dello Sport, editorialista de Il Foglio, e prima direttore de Il Mattino e vicedirettore de Il Messaggero. Laureato in giurisprudenza a Bologna, coordina l’Osservatorio informazione giudiziaria dell’Unione camere penali e presiede la Fondazione Campania dei Festival. Ha insegnato giornalismo alla Sapienza di Roma e in altre università.