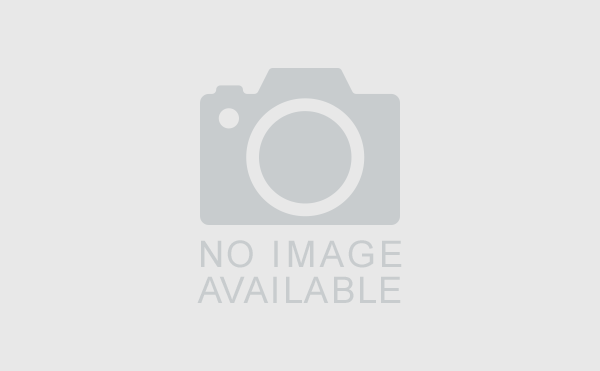L’anno in cui inizio’ l’agonia del Sistema
(da “il Nuovo Riformista” del 15 marzo 2007)
Vent’anni fa, in questi giorni, cominciava l’agonia della prima Repubblica. Il 1° marzo Craxi, che aveva appena ottenuto la cooptazione dell’Italia nel club delle grandi potenze industriali, si doveva dimettere per onorare il patto partitocratrico della “staffettaâ€. Il 28 aprile la Dc, per ottenere le elezioni anticipate, negava la fiducia al monocolore Fanfani che essa stessa aveva voluto per impedire a Craxi di gestire dal governo le stesse elezioni. E a maggio L’Espresso pubblicava un sondaggio da cui risultava che il 65% degli italiani dava un giudizio positivo di Craxi e un giudizio negativo del pentapartito. Lo scollamento fra il Paese e il suo sistema politico non avrebbe potuto essere più evidente.
Anche le forme aiutavano a capirlo. Il sistema, infatti, svelava il proprio barocchismo terminale attraverso una serie di caricature iperboliche: Craxi mandato a casa per evitare che i successi del suo governo fossero oggetto di una verifica elettorale; Fanfani mandato nell’aula di Montecitorio a contare i no di chi lo aveva insediato e i sì di chi lo aveva subito. Quanto al Paese, non è che fosse diventato socialista senza saperlo, come nell’immediato dopoguerra aveva immaginato Giancarlo Vigorelli. Aveva semplicemente trovato una leadership che lo aveva portato fuori dagli anni Settanta, tagliando l’inflazione, favorendo lo sviluppo, riscrivendo il Concordato, ridando un ruolo all’Italia nella comunità internazionale. E anche tagliando le unghie all’assemblearismo, brodo di coltura ideale dell’immobilismo.
Dei cinque anni che seguirono bisognerebbe finalmente scrivere la storia. De Mita che non riesce a stare al governo più di un anno. Occhetto che chiude la pagina del comunismo e non ne apre nessun’altra. Craxi che crede di poter curare il cancro con l’aspirina del Caf. Andreotti che gestisce la pratica del governo col minimalismo del grand commis. L’unico che intuisce la gravità della crisi è Cossiga, che però viene isolato da De Mita, perseguitato da Occhetto, snobbato da Craxi e deprivato da Andreotti del timbro di una controfirma sotto il suo messaggio alle Camere.
Quel messaggio sarebbe da rileggere, sedici anni dopo. Per quello che prevede («il grave pericolo che questo malessere si esprima, presto o tardi, in un comune sentimento di non accettazione dei principi di “legittimità †che prima ancora di quelli di “legalità †sono il fondamento reale dell’osservanza delle leggi e dell’autorità dello Stato»). (…)
Articolo integrale di Luigi Covatta
Commemorazione di un Ventennio
Vent’anni fa, in questi giorni, cominciava l’agonia della prima Repubblica. Il 1° marzo Craxi, che aveva appena ottenuto la cooptazione dell’Italia nel club delle grandi potenze industriali, si doveva dimettere per onorare il patto partitocratrico della “staffettaâ€. Il 28 aprile la DC, per ottenere le elezioni anticipate, negava la fiducia al monocolore Fanfani che essa stessa aveva voluto per impedire a Craxi di gestire dal governo le stesse elezioni. E a maggio L’Espresso pubblicava un sondaggio da cui risultava che il 65% degli italiani dava un giudizio positivo di Craxi e un giudizio negativo del pentapartito.
Lo scollamento fra il paese e il suo sistema politico non avrebbe potuto essere più evidente. Anche le forme aiutavano a capirlo. Il sistema, infatti, ostentava le convulsioni della fase terminale attraverso una serie di caricature iperboliche: del parlamentarismo, attraverso l’inibizione al capo del governo uscente di presentare il suo bilancio direttamente agli elettori; della partitocrazia, attraverso l’inibizione al capo del governo entrante di ottenere la fiducia in Parlamento.
Quanto al paese, non è che fosse diventato socialista senza saperlo, come nell’immediato dopoguerra aveva immaginato Giancarlo Vigorelli. Aveva semplicemente trovato una leadership che lo aveva portato fuori dagli anni Settanta, tagliando l’inflazione, favorendo lo sviluppo, riscrivendo il Concordato, ridando un ruolo all’Italia nella comunità internazionale. Ed anche tagliando le unghie all’assemblearismo, brodo di coltura ideale dell’immobilismo.
Dei cinque anni che seguirono bisognerebbe finalmente scrivere la storia. De Mita che non riesce a stare al governo più di un anno. Occhetto che chiude la pagina del comunismo e non ne apre nessun’altra. Craxi che crede di poter curare il cancro con l’aspirina del CAF. Andreotti che gestisce la pratica del governo col minimalismo del grand commis. L’unico che intuisce la gravità della crisi è Cossiga, che però viene isolato da De Mita, perseguitato da Occhetto, snobbato da Craxi e deprivato da Andreotti del timbro di una controfirma sotto il suo messaggio alle Camere. Â
Quel messaggio sarebbe da rileggere, sedici anni dopo. Per quello che prevede (“il grave pericolo che questo malessere si esprima, presto o tardi, in un comune sentimento di non accettazione dei principi di ‘legittimità ’ che prima ancora di quelli di ‘legalità ’ sono il fondamento reale dell’osservanza delle leggi e dell’autorità dello Statoâ€); per quello che dice (la denuncia di “una carenza decisionale†nella seconda parte della Costituzione, che porta “ad una sorta di paralisi o di asfissia che sembra minacciare l’intero apparato istituzionaleâ€, e l’obiettiva difficoltà del “potere costituito†a farsi “potere costituenteâ€); ed infine per quello che non dice, perché cassato al fine di ottenere l’imprimatur, se non di Andreotti, del guardasigilli Martelli (le undici righe in cui si auspicava un governo di unità nazionale che superasse la conventio ad excludendum).       Â
Ma, come dirà nel 2003 lo stesso Cossiga, “Craxi, impaniato nel CAF, vede più rischi per il PSI che vantaggi da un PCI liberato dal fattore Kâ€, mentre “in pieno travaglio postcomunista il PCI si spaventò†e cominciò a raccogliere firme per portarlo all’Alta Corte. Quanto a De Mita, mentre l’azienda di cui era azionista di maggioranza si apprestava a portare i libri in tribunale, non trovava di meglio che discutere di dual governance, rivendicando i diritti dell’assemblea rispetto a quelli del consiglio d’amministrazione.
Non c’è da stupirsi, quindi, se l’anno dopo gli esecutori dei “principi di legalità †travolsero i rappresentanti dei “principi di legittimità â€, e i politologi sostituirono i politici. Presero la mano anche a Segni, che pure aveva fondato il suo movimento per la riforma elettorale fin dal 1988, ma che mai più avrebbe pensato di diventare, da postulatore di una riforma, il protagonista di una rivoluzione. Mentre a loro volta De Mita, Occhetto e Craxi mai più avrebbero pensato che l’inconcludenza della X legislatura avrebbe portato nell’XI la Lega al 9%.
Il resto è storia nota. La rinuncia a ritoccare la Costituzione per ovviare alla “carenza decisionale†segnalata da Cossiga. L’infelice compromesso sulla legge elettorale. La fretta di Occhetto di andare alle urne. La divina sorpresa dell’avvento di Berlusconi. Il ribaltone con cui si inaugurava la stagione dei governi “eletti dal popoloâ€. Il trasformismo che portava il primo comunista a palazzo Chigi. La moltiplicazione dei partiti con cui si onorava la promessa di una semplificazione del sistema. L’obesa impotenza del secondo governo Berlusconi, ricco di consensi e povero di risultati. Fino al Porcellum, degna conclusione di una transizione verso il nulla e felice coronamento di una stagione ostile all’oligarchia partitocratrica.
La storia fin qui grossolanamente riassunta è durata vent’anni. Quanto il fascismo. Il doppio del degasperismo. Il quadruplo delle leadership di Fanfani e di Craxi. (Ma quasi la metà , ad onor del vero, del doroteismo). Nel vuoto della politica riemergono i politologi. E non è detto che non riemergano, prima o poi, anche gli esecutori dei “principi di legalità â€, benché stremati dalle pulizie che hanno dovuto nel frattempo portare a termine nel mondo bancario, in quello industriale, in quello immobiliare e perfino nel mondo del pallone.
Vent’anni, in politica, sono la durata di un regime, il tempo di una generazione, lo sfondo di un’epoca. Per cui chi vede i segni di una seconda crisi di sistema non abbaia alla luna. Non resta che resettarli, questi vent’anni, se si vuole evitare al paese la definitiva decadenza. E ricominciare, se non dalla tabula rasa, dall’uso delle macerie secondo i principi del restauro creativo. Altro che discutere di riforma elettorale in funzione delle fortune (o delle sfortune) del futuro partito democratico. Altro che cazzeggiare sul modello tedesco per rimettere insieme le figurine del Grande Centro. Altro che correggere il Porcellum per consentire a Berlusconi di godere del premio di maggioranza anche al Senato. Altro che inseguire ancora una volta il Modello Westminster mentre Bayrou batte la Royal e Blair non riesce a governare la sua successione. Ed altro, infine, che schermirsi dietro le insegne di un presunto sistema politico europeo che se esistesse avrebbe già dato una Costituzione all’Unione.
Dopo vent’anni, la festa è finita. Bisogna ricomporsi e ritrovare il senso di realtà . Bisogna, soprattutto, avere qualche progetto, prima di mettere mano ancora una volta al Lego delle riforme elettorali. E bisogna anche avere lo spazio per progettare e per ricostruire. Che le Bicamerali portino sfiga è ormai diventata nozione di senso comune per la politologia pret à porter che ha dominato il ventennio. Politologi meno svagati pensano che la sfiga nasca dall’insopprimibile e già segnalato conflitto fra potere costituito e potere costituente, e che le Bicamerali falliscano soprattutto quando in esse si formino maggioranze diverse da quelle che pro tempore sostengono i governi. Per cui potrebbe perfino darsi che le regole per un’effettiva democrazia dell’alternanza e gli incentivi per dar vita a quella democrazia governante inutilmente perseguita nell’ultimo ventennio passino attraverso le aborrite “grandi intese†o l’esecrando governo istituzionale. Magari grazie alla lunga esperienza di chi ora siede al Quirinale, ed è in grado meglio di altri di percepire la durata dei cicli politici. Ma è fuori dal Quirinale, nell’arena politica, che finora manca lo sguardo lungo di chi pure si appresta a fondare partiti e promuovere federazioni. Come se non fosse chiaro che il nuovo che vuole proiettarsi nel futuro nasce da una nuova lettura del passato, da un cambio di prospettiva rispetto all’apparente realtà del presente.