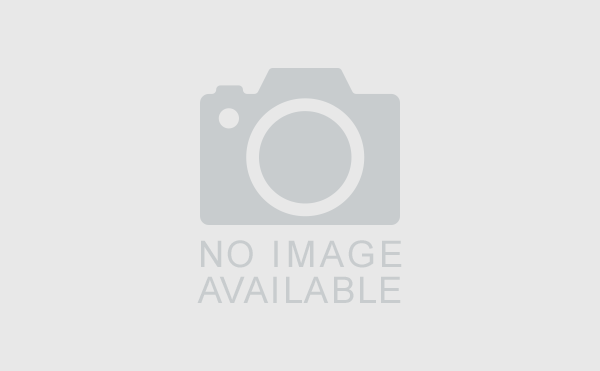Riflessioni sul sequestro Moro
Il 16 marzo si era in campagna elettorale e non c’era modo di sottilizzare. Il 9 maggio aveva appena giurato il governo, e non c’era modo di recriminare. Ora, però, una riflessione sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro sarebbe doverosa. Non per scovare altri “misteri”. Semmai per riconoscere il termine a quo del trentennale declino della Repubblica.
Il sequestro di Moro, infatti, non è materia da giallisti. Non solo perché, come ha scritto Vladimiro Satta, “il caso Moro è di per sé una storia tragica e per esprimere quella grandezza che è insita nelle tragedie non ha davvero bisogno di montature”. Perché non ha bisogno di montature neanche per essere letto come tragedia politica. Non c’è bisogno, cioè, di rovistare nei retroscena per seguire la trama politica che allora fu messa in scena, e che ora Giovanni Moro ha definito “strategia della non decisione”. Una strategia inevitabilmente implicita, e quindi coperta dalle più diverse retoriche, da quella della legalità a quella del pro patria mori, appena aggiornata con riferimenti all’epopea resistenziale. Ma comunque una strategia perseguita con determinazione, tanto da non essere scalfita neanche dalla testimonianza di chi, come Giuliano Vassalli, condusse la sua battaglia per la salvezza di Moro sia con la dottrina del giurista rigoroso che con l’esperienza del partigiano che dopo aver resistito nella prigione di via Tasso aveva trattato per il rilascio di Saragat e Pertini.
Nell’immediato questa strategia significò abbandonare Moro al suo destino, ma in prospettiva al suo destino abbandonò anche il sistema politico, se è vero che nei comportamenti delle forze politiche durante quei cinquantacinque giorni si possono ben cogliere i primi e determinanti segni di una resa della politica, l’inizio di quella grande slavina che sarebbe poi precipitata a valle nei primi anni ‘90. Che poi la slavina abbia travolto per primo l’unico uomo politico che allora aveva cantato fuori dal coro è un dettaglio: come si vede in questi giorni, la storia non paga il sabato.
Allora le forze politiche rinunciarono a dialogare con Moro (a “dialettizzarsi” con lui, come aveva suggerito Curcio), non considerando che nelle sue lettere (in quelle lettere che trent’anni fa per molti non erano “sue”, ed alle quali ora si dedica addirittura un’edizione critica) c’era non solo l’indicazione di un itinerario ragionevole per la soluzione della crisi contingente, ma “uno dei documenti più drammatici e importanti della storia della Repubblica”, come ha scritto di recente Piero Craveri.
Craveri, che definisce la “fermezza” della DC espressione di “superficiale ignavia”, osserva che nel decennio successivo al “parricidio rituale” di Moro il gruppo dirigente democristiano non avrebbe “ritrovato più la ragione profonda della propria identità” ed avrebbe dimostrato che “senza Moro era costituito politicamente da nessuno”. Trent’anni dopo è difficile dargli torto. Così come è difficile sottovalutare la nota del 2 aprile 1978 di Tatò per Berlinguer, che nel comprensibile intento di distinguere dal drammatico processo realmente messo in piedi dalle BR i virtuali “processi alla DC” tante volte evocati dalla propaganda comunista sosteneva che “la DC non va messa sotto processo, ma va stretta politicamente per spostarla in avanti, per dislocarla, per farla cambiare”, con vere e proprie purghe nei confronti delle correnti democristiane di destra e dei responsabili della “svendita della sovranità nazionale“.
Il trentennale del sequestro e dell’assassinio di Moro si è mescolato non sempre felicemente col quarantennale della contestazione giovanile. Nessuno, fra l’altro, si è chiesto come mai in Italia il Sessantotto è durato dieci anni. Anche in questo caso per capirlo serve “dialettizzarsi” con Moro. Con un uomo politico, cioè, che del Sessantotto aveva intuito la dimensione epocale, ma che aveva evitato di lisciare il pelo alla sua dimensione effimera. Al contrario di quello che avevano fatto le forze che poi non furono in grado di salvarlo dal prevedibile epilogo di un decennio durante il quale esse avevano largamente abdicato al pieno esercizio della responsabilità politica e si erano limitate ad alternare carota e bastone nel rapporto col movimento dei giovani. Per cui il pericolo della sudamericanizzazione da esse paventato nel ’78 per giustificare la “fermezza” può ben essere considerato, se non proprio una profezia che si autoadempie, un esito largamente condizionato dalle omissioni di cui era stato punteggiato il decennio precedente.
La vulgata vuole che la “fermezza” abbia comunque sconfitto il terrorismo. Ancora due anni dopo quel 9 maggio, però, l’appeal del partito armato era tale da indurre giovanotti della Milano bene ad assassinare Walter Tobagi per sostenere una sorta di esame d’ammissione alle BR. Meglio quindi riconoscere che il terrorismo venne sconfitto molto dopo, grazie a quella specie di trattativa di massa ed a quel gigantesco scambio di prigionieri che seguirono ad una legislazione premiale che produsse uno strappo al principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ben più grave di quello che si sarebbe determinato “se, una volta tanto, un innocente sopravvive e, a compenso, altra persona va, invece che in prigione, in esilio”.
Allora, come si è detto, si fece spreco di ossequi al “principio di legalità”. Ma proprio Moro, nella sua prima lettera a Cossiga, aveva smontato da fine giurista la correttezza di quel riferimento, ed aveva evocato in controluce il principio della ragion di Stato. Chi sa che Cossiga non pensasse anche a questo quando, nel profetico messaggio alle Camere del 1991, paventò l’avvento di “un comune sentimento di non accettazione dei principi di legittimità che prima ancora di quelli di legalità sono il fondamento reale dell’osservanza della legge e dell’autorità dello Stato”.
Anni dopo, del resto, la distinzione fra legittimità e legalità non sfuggì a un altro giurista rigoroso come Franco Cordero, che sulla Repubblica dell’11 ottobre 2003 demolì da par suo le ragioni del fronte legalitario. Innanzitutto contestò “la colpa dello Stato nell’avvenimento che insanguina via Fani”, perché era responsabilità dello Stato proteggere Moro, e “quanto male vi provvedessero i responsabili consta dall’assurda strage”. Negò la logica degli atti successivi delle autorità, che fecero sorgere “il dubbio che non lo cerchino” mentre era evidente che, se “non l’hanno protetto” e ora “sta in mano ai sequestratori”, logica vuole che “lo salvino”. Accusò di “ignorantia elenchi” quanti, per negare alle BR un “riconoscimento politico” che esse non avevano richiesto, negarono invece lo scambio di prigionieri che esse avevano richiesto. Ricordò che Giulio Cesare, quando viene rapito, paga il riscatto e poi “arma una piccola flotta, insegue i rapitori, li cattura e impicca”. Deplorò “i santoni” che Moro “lo seppelliscono vivo” per fare “gli eroi sulla pelle altrui”. Negò il macabro teorema per cui Moro doveva “morire perché sono morti cinque”, dal momento che i cinque “avevano un compito, difenderlo dalle aggressioni; non era comoda sinecura; sia colpa loro o dei loro superiori, non l’hanno adempiuto; riposino in pace; salvate lui, piuttosto”. Infine contestò l’opportunità politica di esigere un rilascio “senza condizioni”, questo sì occasione per le BR di “enorme prestigio”, perché “una mossa da signori benevoli vale più di ogni riscatto”.
Quella mossa, come è noto, i brigatisti non seppero e non vollero farla perché non erano signori benevoli e non erano neanche politici intelligenti. Ma i signori benevoli e i politici intelligenti scarseggiarono anche sul versante dello Stato. Fino all’esito catastrofico cui sempre si giunge quando si scontrano due opposte e simmetriche impotenze.
09 maggio 2008