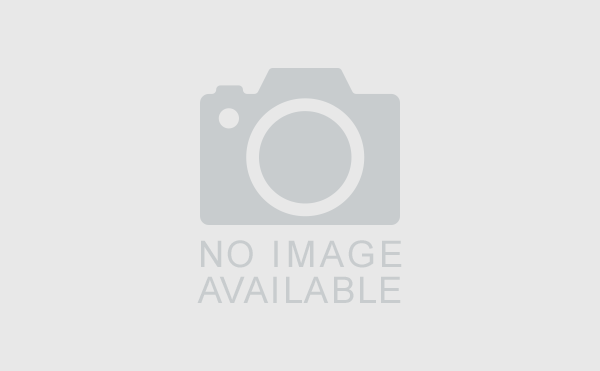Quanto pesò la svolta riformista di 25 anni fa
(da “il Nuovo Riformista” del 28 marzo 2007)
Curiosamente venticinque anni fa fu La Repubblica, già allora poco tenera con Craxi, a cogliere meglio la novità rappresentata dalla Conferenza programmatica del Psi che si aprì a Rimini il 31 marzo. Giuseppe Turani vide nelle proposte socialiste una strategia finalizzata a «consentire al sistema economico di correre più in fretta e meglio» verso la terza rivoluzione industriale e verso «la Grande Competizione, nella quale entriamo con un carico di disoccupati e di problemi intollerabile».
Si trattava di «una politica del credito via via più permissiva per tenere alti gli investimenti, in modo da creare nuove occasioni di lavoro e da mantenere competitivo il sistema produttivo», della «richiesta ai lavoratori di essere più “mobiliâ€, più flessibili, proprio per non ostacolare gli aggiustamenti oggi indispensabili in tutto il complesso produttivo», nonché di «un ridisegno del welfare state, che deve diventare welfare society, per non ingigantire la spesa pubblica». E Miriam Mafai spiegò che la nuova piattaforma del Psi nasceva dal «riconoscimento di una complessità sociale sulla quale non è pensabile intervenire con un rigido disegno programmatorio», per cui il programma si articolava in «una serie di proposte, a nessuna delle quali viene affidato il valore risolutivo che venne affidato, ad esempio, nel primo centrosinistra alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, ma miranti complessivamente a rilanciare una politica degli investimenti e a salvaguardare lo Stato del benessere ripulito dalle incrostazioni parassitarie, dal malgoverno e dalla burocratizzazione».
Per questo era logico che «la forte carica programmatoria che nel primo centrosinistra era indirizzata sul sistema economico» si trasferisse ora «sul problema delle istituzioni e del funzionamento dello Stato», con «proposte miranti a dare maggiore stabilità all’esecutivo e a garantire il funzionamento di uno Stato di cui è stata denunciata la disgregazione ed il corrompimento». Ma andava soprattutto sottolineata «una visione della società che fa tabula rasa non solo delle tradizionali analisi della sinistra, ma anche di ogni forma di antagonismo sociale», per cui «alla contrapposizione destra-sinistra si è sostituita la contrapposizione vecchio-nuovo, arretrato-moderno», fino a derivarne «un atteggiamento complessivo di ottimismo e di fiducia, che punta su tutti gli elementi dinamici della società ». (…)
Articolo integrale di Luigi Covatta
Non fece granchè notizia
Curiosamente venticinque anni fa fu La Repubblica, già allora poco tenera con Craxi, a cogliere meglio la novità rappresentata dalla Conferenza programmatica del PSI che si aprì a Rimini il 31 marzo. Giuseppe Turani vide nelle proposte socialiste una strategia finalizzata a “consentire al sistema economico di correre più in fretta e meglio†verso la terza rivoluzione industriale e verso “la Grande Competizione, nella quale entriamo con un carico di disoccupati e di problemi intollerabileâ€. Si trattava di “una politica del credito via via più permissiva per tenere alti gli investimenti, in modo da creare nuove occasioni di lavoro e da mantenere competitivo il sistema produttivoâ€, della “richiesta ai lavoratori di essere più ‘mobili’, più flessibili, proprio per non ostacolare gli aggiustamenti oggi indispensabili in tutto il complesso produttivoâ€, nonché di “un ridisegno del welfare state, che deve diventare welfare society, per non ingigantire la spesa pubblicaâ€. E Miriam Mafai spiegò che la nuova piattaforma del PSI nasceva dal “riconoscimento di una complessità sociale sulla quale non è pensabile intervenire con un rigido disegno programmatorioâ€, per cui il programma si articolava in “una serie di proposte, a nessuna delle quali viene affidato il valore risolutivo che venne affidato, ad esempio, nel primo centro sinistra alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, ma miranti complessivamente a rilanciare una politica degli investimenti e a salvaguardare lo Stato del benessere ripulito dalle incrostazioni parassitarie, dal malgoverno e dalla burocratizzazioneâ€. Per questo era logico che “la forte carica programmatoria che nel primo centro sinistra era indirizzata sul sistema economico†si trasferisse ora “sul problema delle istituzioni e del funzionamento dello Statoâ€, con “proposte miranti a dare maggiore stabilità all’esecutivo e a garantire il funzionamento di uno Stato di cui è stata denunciata la disgregazione ed il corrompimentoâ€. Ma andava soprattutto sottolineata “una visione della società che fa tabula rasa non solo delle tradizionali analisi della sinistra, ma anche di ogni forma di antagonismo socialeâ€, per cui “alla contrapposizione destra-sinistra si è sostituita la contrapposizione vecchio-nuovo, arretrato-modernoâ€, fino a derivarne “un atteggiamento complessivo di ottimismo e di fiducia, che punta su tutti gli elementi dinamici della società â€.
Sugli altri giornali, invece, la Conferenza socialista non fece granchè notizia. In quei giorni, del resto, i quotidiani dedicavano paginate agli ultimi sviluppi del caso Cirillo, con l’assassinio di Semerari e il memoriale di Rotondi. Tanto che della Conferenza rischiò di diventare principale testimonial il sottosegretario Scamarcio, il quale aveva avuto il torto di dire dalla tribuna quello che tutti dicevano nei corridoi sui traffici fra Cutolo e la DC. L’Espresso, che nello stesso numero scomodava Forcella, Cafagna, Gambino, Caffè e Colletti per tracciare un bilancio (per la verità non encomiastico) del primo decennale della segreteria Berlinguer, se la cavò con due paginette. Ed altrettanto spazio ebbe Filippo Ceccarelli su Panorama per illustrare, peraltro non banalmente, come si sarebbe vissuti “domani a Craxilandiaâ€.
La stampa, in realtà , fu spiazzata innanzitutto dalla natura dell’evento. Non era consueto vedere alternarsi a una tribuna di partito Massimo Severo Giannini e Salvo Andò, Stefano Silvestri e Riccardo Lombardi, Federico Mancini e Claudio Signorile, Enzo Cheli e Gianni De Michelis, Alberto Spreafico e Rino Formica, Franco Reviglio e Valdo Spini, Ettore Gallo ed Enrico Manca, Gianni Baget Bozzo e Silvano Labriola, Luciano Gallino e Fabrizio Cicchitto, Francesco Alberoni e Claudio Martelli, Gino Giugni e Carlo Ripa di Meana, Giorgio Ruffolo ed Enzo Mattina, Francesco Forte ed Ottaviano Del Turco, Giovanni Bechelloni e Giorgio Benvenuto, Alberto Martinelli e Nicola Capria, Gianni Statera e Margherita Boniver. Se poi quel partito era il PSI, che fin dai tempi della nenniana politique d’abord si era distinto per iperpoliticismo, era logico che gli inviati si aspettassero di dover decifrare un dibattito tutto pronunciato in politichese, fra preamboli ed equilibri più avanzati. Anche se non fu per distrazione che l’Unità , per la penna di un Antonio Caprarica insolitamente supponente, denunciò il proposito di “rivedere la Costituzione per puntellare i governi†e ironizzò su Martelli che“insegna al PSI che le classi non esistonoâ€, ispirato da un Alberoni “fresco da un’intervista ad Amica corredata dalle foto dei modelli del noto stilista Versaceâ€.
In realtà Martelli non si era limitato, otto anni dopo il saggio di Sylos Labini, ad auspicare che si abbandonasse “la sociologia pietrificata delle classi che abbiamo ereditato dal marxismoâ€, ma aveva rovesciato la posizione del PSI nel “duello a sinistra†che fino ad allora aveva combattuto in difesa. “Noi non ci siamo posti il compito di produrre una rivoluzione che non c’èâ€, aveva detto andando all’assalto del PCI tardoberlingueriano, “ma quello di rappresentare politicamente e di governare con l’efficacia della politica democratica la rivoluzione che è in attoâ€. Ed aveva spiegato che la nuova alleanza riformista doveva avere per protagonisti “le donne e gli uomini di merito, di talento, di capacità †e “le donne e gli uomini immersi nel bisognoâ€. I primi “sono persone utili a sé e agli altriâ€, perché sono “coloro che progrediscono e che fanno progredire l’intera società con il loro lavoro, con la loro immaginazione, con la loro creatività , con il produrre più conoscenzeâ€, e quindi “sono coloro che possono agireâ€. I secondi “sono le persone che non sono poste in grado di essere utili a sé e agli altri, coloro che sono emarginati o dal lavoro o dalla conoscenza o dagli affetti o dalla saluteâ€, e quindi “sono coloro che devono agireâ€.
C’era di che discutere per un PCI che pure era impegnato a leggere “da sinistra†la crisi dello Stato sociale, ed era passato dall’esperimento fallimentare dell’eurocomunismo all’esplorazione di quella “eurosinistra†da cui sarebbero nati il New Labour e la Neue Mitte. Invece Berlinguer, dopo avere criticato Lama per avere solidarizzato con Benvenuto dopo i fischi dei metalmeccanici a piazza San Giovanni, e dopo avere definito “riduttiva la contrapposizione fra antico e modernoâ€, mobilitò le masse “contro il rischio delle elezioni anticipateâ€.
Neanche a destra, peraltro, le novità socialiste vennero granchè apprezzate. La DC reagì con sconcerto all’ipotesi che i socialisti al governo non fossero più i fratelli scemi dei comunisti e pretendessero addirittura una qualche “centralità â€. E Confindustria, lasciò cadere perfino la proposta di Giugni di rivedere lo Statuto dei lavoratori e le norme sul collocamento per consentire maggiore flessibilità alle imprese.
Quanto a Craxi, con la Conferenza di Rimini diede un contenuto all’autonomia socialista ed al PSI un ruolo diverso da quello di interdizione che la geografia del sistema politico gli aveva assegnato. Giocò allora la sua scommessa, che nei cinque anni di governo sembrò vincente, e nei cinque anni successivi risultò catastroficamente perdente. Adesso, alla fine di un altro ciclo, bisognerebbe almeno stabilire se quella scommessa la perse per avere osato troppo o troppo poco.