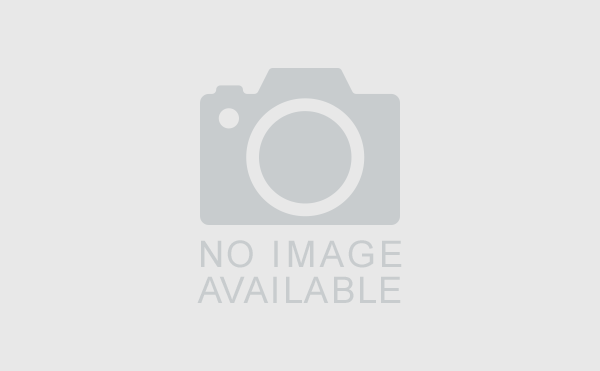La Destra immobile
Dopo la fase di ristagno subentrata alla stagione congressuale di Ds e Margherita, il dibattito politico si è rianimato, a Roma come a Napoli, che sempre riflette e spesso anticipa i temi in discussione nella capitale.
A Roma, per esempio, scricchiola l’intesa tra diessini e diellini sulla data d’inizio della fase costituente del Pd: i primi insistono per l’autunno, i secondi vorrebbero anticiparla a giugno, ma a Napoli già nei giorni scorsi esponenti diessini (Bossa) e dieIlini (Villari) avevano proposto di anticipare al massimo le procedure d’unificazione dei due partiti. E mentre a Roma salta l’intesa di centrosinistra sulle fondazioni, che poteva risolvere in anticipo il contenzioso sui beni dei partiti, a Napoli divampa la polemica tra Margherita e Udeur per le candidature alle amministrative, il senatore Barbieri lascia i Ds e critica la nascita dei Pd, arrivano Fassino e Boselli per discutere di Mediterraneo ma anche del coinvolgimento socialista nel nuovo, partito, l’area Mussi rafforza le tesi che daranno vita oggi a Roma alla Sinistra democratica.
E ripreso insomma il fervore delle idee e delle polemiche, come sempre accade quando si preparano nuovi rapporti di forza in un’area politica. Ma, viceversa, è proprio la mancanza di capacità progettuale che continua a sorprendere nell’ambito del centro-destra, a Roma come a Napoli. Così, mentre il dibattito nella maggioranza è caratterizzato dalla ricerca di una sintesi condivisa tra il sogno americano di Fassino, Veltroni e Rutelli e il pragmatismo identitario di Marini, Parisi e De Mita, o dalla diaspora di Mussi, Angius e altri e dalla possibilità di nuove aggregazioni a sinistra, sul versante opposto si segna il passo. E ciò non è utile nemmeno al centro-sinistra, che non trova stimoli adeguati nell’opposizione e, per l’area territoriale che ci riguarda, induce ad alcune riflessioni. Napoli continua ad affondare le sue radici di destra nel populismo qualunquistico rifiutando ogni tentativo d’integrazione sociale del proletariato con la piccola e media borghesia produttiva che altrove, ad esempio nel centronord italiano o nell‘Europa franco-tedesca, rappresenta la base dei cosiddetti â€partiti d’ordine†o del popolarismo democratico.  Mentre i moderati di Napoli e del resto della regione continuano a dare fiducia al centrismo cattolico e ai suoi vecchi alleati della prima repubblica. Rispetto all’assetto politico francese, per meglio chiarire, il centrodestra campano può definirsi molto più vicino a Le Pen e Sarkozy che a Bayrou. In altri termini, invece di puntare al superamento e alla saldatura tra le classi che la società post-industriale comporta, come ora sta cercando di fare il centrosinistra,esso alimenta il divario sociale e finisce per favorire involontariamente gli interessi della camorra, la cui prospettiva si regge proprio sulla divisione considerata incolmabile e “fatale†tra ceti ricchi e ceti poveri, tra il potere del denaro e la dannazione sociale della miseria. Da cui la sua idea di una democrazia ancora “muscolareâ€, senza però avere i “muscoliâ€, cioè gli uomini adatti per attuarla. Da qui le ripetute sconfitte sui piano elettorale di fronte all’asse Sassolino-De Mita, che di “muscoli†è fornito e che del consolidamento del blocco del potere costituito ha fatto sino a ieri la sua carta vincente. Ma ciò, nella prospettiva del Partito democratico, al centrosinistra campano ora non è più concesso. Se continuasse a farlo, l’operazione rinnovamento fallirebbe in partenza o nascerebbe asfittica. Venuto meno il concetto del partito-ideologia e tramontata l’idea di poter rappresentare gli interessi di tutte le classi, la nuova formazione politica dovrà farsi carico di una visione generale ma condivisa dei problemi e delle esigenze di sviluppo del territorio, anziché perpetuare la di fesa d’interessi settoriali e dei vecchi serbatoi del consenso. Ma c’è un altro rischio  da evitare, ci sembra, sia nel centrosinistra che nel centrodestra. Ed è quello che il ricorso alla società civile, ossia alla democrazia partecipativa, che alcuni sui due fronti invocano per superare gli squilibri della politica dei partiti, indebolisca di significato la democrazia della rappresentanza, cioè il pilastro della vita democratica dell’occidente. Investiture plebiscitarie di governatori o sindaci, oppure di presidenti o premier,possono diventare il passaggio indolore verso forme di rappresentanza troppo personalizzate, che vanno contro la natura stessa della della Democrazia. E allora forse bisogna intendersi meglio sui concetti di partecipazione e di pluralità .Il primo obiettivo nasce dall’incrocio effettivo tra domanda e offerta. Ma dal primo lato i partiti sono sfuggenti, le primarie nessuno si decide a convocarle. Mentre la cosiddetta società civile stenta a “offrirsi†come interlocutore seriamente interessato. Quanto alla pluralità delle voci politiche, che dovrebbe essere contenuta da un lato dal Partito democratico e dall’altro dal partito unico di Berlusconi o dalla federazione proposta da Fini in Campania è una realtà storicamente molto difficile da controllare o da contenere. Secondo alcuni, il fenomeno rappresenta una ricchezza democratica a cui sarebbe sbagliato rinunciare. Secondo altri, può portare alla ulteriore frammentazione e quindi alla degenerazione della democrazia, che è nata per unire e non per dividere. Ma per unire occorrono partiti forti e uomini, o donne, che sappiano guidarli amalgamando senza squilibri tra un’istanza e l’altra i principi di rappresentanza e partecipazione. A Napoli e alla Campania, non bastando uno come Bayrou, occorrerebbero forse leader più aggreganti come Ségolène Royal, se domani riuscirà a spuntarla.